
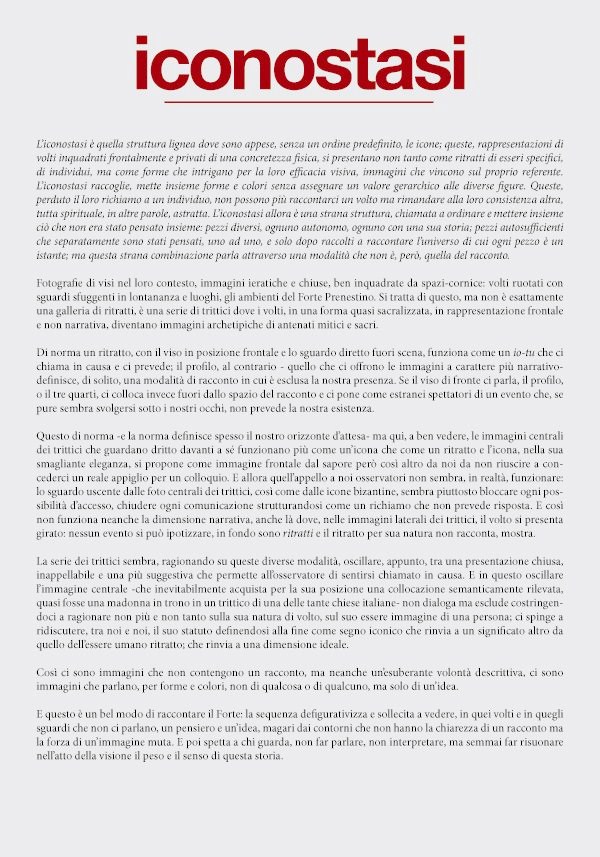





Iconostasi
L’iconostasi è quella struttura lignea dove sono appese, senza un ordine
predefinito, le icone; queste, rappresentazioni di volti inquadrati frontalmente
e privati di una concretezza fisica, si presentano non tanto come ritratti di
esseri specifici, di individui, ma come forme che intrigano per la loro
efficacia visiva, immagini che vincono sul proprio referente. L’iconostasi
raccoglie, mette insieme forme e colori senza assegnare un valore gerarchico
alle diverse figure. Queste, perduto il loro richiamo a un individuo, non
possono più raccontarci un volto ma rimandare alla loro consistenza altra,
tutta spirituale, in altre parole, astratta. L’iconostasi allora è una strana
struttura, chiamata a ordinare e mettere insieme ciò che non era stato pensato
insieme: pezzi diversi, ognuno autonomo, ognuno con una sua storia; pezzi
autosufficienti che separatamente sono stati pensati, uno ad uno, e solo dopo
raccolti a raccontare l’universo di cui ogni pezzo è un istante; ma questa
strana combinazione parla attraverso una modalità che non è, però, quella del
racconto.
Fotografie di visi nel loro
contesto, immagini ieratiche e chiuse, ben inquadrate da spazi-cornice: volti
ruotati con sguardi sfuggenti in lontananza e luoghi, gli ambienti del Forte.
Si tratta di questo, ma non è esattamente una galleria di ritratti, è una serie
di trittici dove i volti, in una forma quasi sacralizzata, in rappresentazione
frontale e non narrativa, diventano immagini archetipiche di antenati mitici e
sacri.
Di norma un ritratto, con il
viso in posizione frontale e lo sguardo diretto fuori scena, funziona come un io-tu che ci chiama in causa e ci
prevede; il profilo, al contrario – quello che ci offrono le immagini a
carattere più narrativo- definisce, di solito, una modalità di racconto in cui
è esclusa la nostra presenza. Se il viso di fronte ci parla, il profilo, o il
tre quarti, ci colloca invece fuori dallo spazio del racconto e ci pone come
estranei spettatori di un evento che, se pure sembra svolgersi sotto i nostri
occhi, non prevede la nostra esistenza.
Questo di norma -e la norma
definisce spesso il nostro orizzonte d’attesa- ma qui, a ben vedere, le
immagini centrali dei trittici che guardano dritto davanti a sé funzionano più
come un’icona che come un ritratto e l’icona, nella sua smagliante eleganza, si
propone come immagine frontale dal sapore però così altro da noi da non
riuscire a concederci un reale appiglio per un colloquio. E allora quell’appello
a noi osservatori non sembra, in realtà, funzionare: lo sguardo uscente dalle
foto centrali dei trittici, così come dalle icone bizantine, sembra piuttosto
bloccare ogni possibilità d’accesso, chiudere ogni comunicazione strutturandosi
come un richiamo che non prevede risposta. E così non funziona neanche la dimensione
narrativa, anche là dove, nelle immagini laterali dei trittici, il volto si
presenta girato: nessun evento si può ipotizzare, in fondo sono ritratti e il ritratto per sua natura
non racconta, mostra.
La serie dei trittici sembra,
ragionando su queste diverse modalità, oscillare, appunto, tra una
presentazione chiusa, inappellabile e una più suggestiva che permette
all’osservatore di sentirsi chiamato in causa. E in questo oscillare l’immagine
centrale -che inevitabilmente acquista per la sua posizione una collocazione
semanticamente rilevata, quasi fosse una madonna in trono in un trittico di una
delle tante chiese italiane- non dialoga ma esclude costringendoci a ragionare
non più e non tanto sulla sua natura di volto, sul suo essere immagine di una
persona; ci spinge a ridiscutere, tra noi e noi, il suo statuto definendosi
alla fine come segno iconico che rinvia a un significato altro da quello
dell’essere umano ritratto; che rinvia a una dimensione ideale.
Così ci sono immagini che non
contengono un racconto, ma neanche un’esuberante volontà descrittiva, ci sono
immagini che parlano, per forme e colori, non di qualcosa o di qualcuno, ma
solo di un’idea. E questo è un bel modo di raccontare il Forte Prenestino: la
sequenza defigurativizza e sollecita a vedere, in quei volti e in quegli
sguardi che non ci parlano, un pensiero e un’idea, magari dai contorni che non
hanno la chiarezza di un racconto ma la forza di un’immagine muta. E poi spetta
a chi guarda, non far parlare, non interpretare, ma semmai far risuonare
nell’atto della visione il peso e il senso di questa storia.

